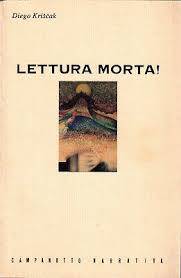
Lettura morta!
Una città trasfigurata dalla tragedia incombente di un morbo inarrestabile, dove l'umanità in bilico tra i ricordi percorre il cammino verso l'unica possibile salvezza: la negazione della memoria.
Attraversando passato e presente senza sosta, la simbologia guida l'io narrante costringendolo alla solitudine inerte e concedendogli un solo atto creativo: riempire i vuoti dell'esistenza con i ricordi, pur sapendo che ciò lo può condurre all'autodistruzione.
un estratto
I fantasmi che credevo ormai lontani persi dimenticati via!.. anni luce, talvolta bussano alla mia porta. Sempre alla sera comunque e sempre mi trovano da solo. Li accolgo a braccia aperte, come si fa con i vecchi amici. Questi fantasmi amichevoli generalmente mi fanno piangere, ma senza cattiveria, senza malizia. Lo fanno perché mi amano, o mi hanno amato un tempo. E' soltanto questo che mi fa piangere, ma mai prima del quinto bicchiere. Lo giuro. A volte ci facciamo delle sonore risate che suonano liquide come la pioggia d'autunno. Liquide e battenti. Incessanti. Quasi un'agonia allora comincia a salire e solo il sonno riesce a mettere tutto a tacere. Altre volte invece partecipa amichevolmente pure lui e contribuisce con segnali che spuntano da dietro la nuca. Un ricordo. Uno spunto nostalgico. Qualche allucinazione condita con scaglie di memoria e ogni cosa precipita a valle preda della corrente che pretenderebbe di decidere per tutti. Poi in realtà esistono pure i salmoni che spinti dalla solita smania la corrente la risalgono. E come i salmoni i ricordi risalgono lungo i miei gangli e si arrampicano fino alla cima e da lì poi incuranti mi salutano senza misericordia. Passano così le serate e le nottate e le giornate e ancora un'altra volta. Fino all'esaurimento del materiale mnemonico. Dovrà pur finire, mi dico allora. Dovrò pure crearmi dei nuovi ricordi. Delle nuove parvenze.
recensioni
Lettura morta!,
il libro delinea un triste paesaggio metropolitano segnato dalla banalità del consumismo
Un libro difficile, complesso, che l’editore Campanotto di Udine non ha esitato a pubblicare. Un libro che incuriosisce sin dalle prime righe, quando ci si rende conto della struttura circolare, di un inizio che si collega con la fine e mostra che non c’è scampo, non c’è altra possibilità, non si esce dai confini in cui il protagonista vive, come dice lo stesso autore.
Le frasi spaccate, brevi, spesso senza verbo, contribuiscono a creare, insieme a parole accostate in maniera dissacrante, con coraggio, una sorta di scenografia, un paesaggio scarno, triste, metropolitano, forse in bianco e nero. È un mondo notturno, quello di kriščák, popolato di bar, risvegli, bicchieri e uomini e donne balorde, e che per questo suoi temi può essere collegato a uno stile contemporaneo che parla della vita urbana e della gente della notte, critica la modernità e la sua espressione più banale, il consumismo.
È un mondo attanagliato da una malattia, un morbo, una peste, che è il filo conduttore del libro. Una malattia cui pochi sopravvivono, che permette un unico atto creativo, il ricordo, che ha lo scopo di riempire il vuoto dell’esistenza. Ricordare, per il protagonista, diventa quindi un atto di coraggio, perché – dice l’autore – la memoria può portare all’autodistruzione. Il filo della narrazione corre dunque tra sogni, risvegli e ricordi, tutti necessari al protagonista, all’io narrante, per giungere a un’accettazione della realtà. Un libro difficile, dicevamo, controcorrente, lontano dalla attuale tendenza alla semplificazione e alla destrutturazione della letteratura.
Francesca Capodanno (1997)
Non c’è più posto per i sognatori
Chi rimane fedele ai propri sogni è destinato a morire, come Teresa, la donna che l’io narrante ha desiderato a prima vista e che effettivamente gli riempirà la vita; ma il timore della peste porta a eliminare anche i suoi oggetti, le sue reliquie.
Esiste, in realtà, una contraddizione tra il ricorso alla memoria, come unica risorsa in uno stato d’assedio – l’impossibilità di uscire da una città blindata, circondata da un muro d’acciaio presidiato dai militari – e la necessità di sopprimerla per evitare il contagio. Vale a dire: meglio essere morti o dei morti-vivi, come i fantocci che popolano questo romanzo? Ed ecco il barista che, con l’esca del reaglino, trascina i ragazzini nel retrobottega, le prostitute sanguisughe, i giovani che si accoppiano meccanicamente, perché «amano talmente loro stessi da cancellare con le carezze mal dosate l’immagine dell’altro».
Uomini senza rapporti, senza slanci, senza pietà. Solo all’interno dell’ospedale, di fronte al compagno di stanza che muore, la pietà può esplodere a tradimento, troppo grande per essere sopportata.
È così che siamo ridotti? Incapaci di coinvolgimento, di comprensione, di rimpianti, concentrati solo sulla spravvivenza; incapaci di libertà perché soggiogati da un potere reclamizzato da comizi televisivi. È questo il post-moderno, dove lo spessore della tradizione è annullato dal mostruoso proliferare della civiltà urbana, dove gli ideali si liquefano come i cadaveri ammucchiati, dove le rivoluzioni non hanno più radici per attecchire?
Persone conservate in barattoli di vetro, come marmellata: per neutralizzare i loro sguardi, i loro sorrisi, bisogna chiuderli sotto vuoto spinto. È questa la grottesca soluzione per sopravvivere in un mondo dove i sentimenti, la partecipazione, l’autenticità vanno rimossi, pena la morte.
È un’atmosfera da fine millennio quella del libro d’esordio di un giovane triestino, Diego Kriscak, 37 anni portati con un precoce senso della precarietà della vita, con una tendenza all’introspezione che conduce a livelli tormentosi di consapevolezza. Il titolo perentorio «Lettura morta!» (Campanotto, pagg. 106, lire 18 mila), conferma la vena pessimistica: come spiega l’autore, per il protagonista non c’è via di scampo, mentre l’uso del punto esclamativo viene motivato con la visualizzazione di un colpo secco, quello della pietra tombale che si chiude.
La cornice, pretesto per il dipanarsi di un flusso di coscienza che non lascia spazio al concretizzarsi di eventi, non è nuova: un morbo sconosciuto, ovvero la peste, è stato più volte usato come spunto letterario, con diversi significati simbolici. In questo caso, la necessità di mettere anche la propria personalità sotto vetro (per non cedere alla tentazione di dare spazio ai ricordi di una vita dove tutto era ancora possibile, poiché «ogni ricordo è un chiodo sulla bara»), può forse alludere a una società che non consente di porsi obiettivi o intrattenere rapporti che esulino dalla logica della mercificazione. La condanna dell’uomo moderno assume le sembianze di un grande supermercato.
Ma forse le ultime considerazioni riguardano in particolare Trieste, la cui inerzia, la cui mancanza di reazioni vengono descritte senza mezzi termini: «appartengo a una razza che non sa odiare; non sa essere violenta, ma di quella violenza positiva, di quella violenza che purifica. Probabilmente il latte delle nostre madri è già viziato… già nelle prime giornate della nostra esistenza… si prepara il nostro rassegnato futuro. Siamo i mozzi di una nave che è già affondata».
E su altre prospettive apocalittiche si potrebbe spaziare partendo da questo libro, ostico e volutamente ripetitivo che, per l'avvolersi su se stessa di un'angoscia esistenziale, assume a modello Thomas Bernhard. Altri richiami, per la crudezza di alcune descrizioni e il linguaggio disinibito, si collegano invece alla letteratura americana della "beat generation". Dato il tema e l'entità dei modelli, il libro si pone delle mete un po' ambiziose, ciò non toglie che, da un andamento discontinuo, tipico di un'opera prima, emergano pagine di notevole efficacia.
Giorgetta Dorfles (1997)